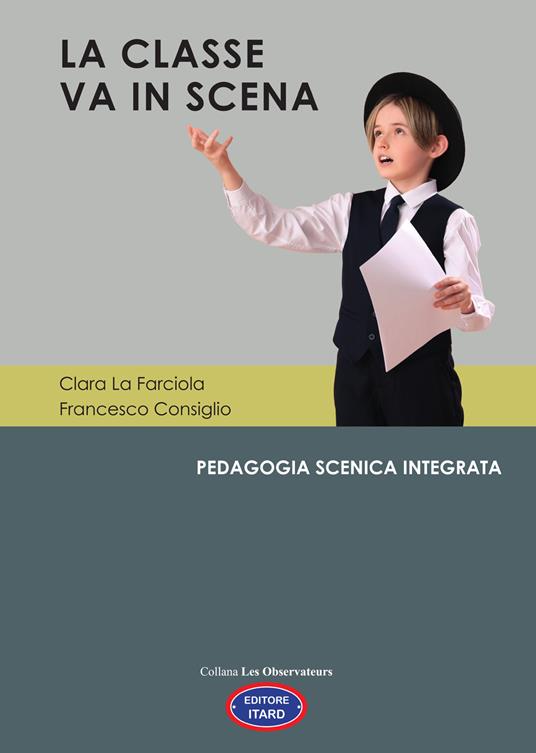COACHING
Come si svolge una sessione individuale di coaching scolastico con la Pedagogia Scenica Integrata.
Tutto inizia prima ancora che lo studente entri nello spazio scenico. Il primo passo è sempre un colloquio preliminare con i genitori. Questo momento è fondamentale per raccogliere informazioni sul contesto scolastico, sulle fatiche riscontrate, sulle dinamiche familiari, sulle aspettative. Si ascolta, si osserva, si chiede, ma soprattutto si chiarisce: non si tratta di un supporto clinico né terapeutico, ma educativo. Il coach non cura, non fornisce diagnosi, ma costruisce insieme un percorso per aiutare il ragazzo o la ragazza a ritrovare fiducia, motivazione e strumenti efficaci per apprendere. Alla fine del colloquio viene concordata la formula più adatta: frequenza, modalità (in presenza o online), obiettivi generali.
Durante la prima seduta con lo studente, l'approccio è calibrato sull'età e sul suo stile di apprendimento. Con i bambini della scuola primaria, si lavora molto sul gioco simbolico, sull'esplorazione di emozioni e stati d'animo attraverso il corpo, su storie inventate e personaggi immaginari. Si comincia spesso con un "rito d'ingresso": togliere le scarpe, scegliere uno spazio nel tappeto, camminare in cerchio con un ritmo libero, poi condividere una parola che racconti come ci si sente quel giorno. Si passa poi a giochi di attenzione e concentrazione (come "statua e movimento" o "la macchina emotiva", in cui ogni bambino rappresenta con il corpo una emozione che viene attivata da un suono o da un gesto del coach). A questo segue un momento più narrativo, dove il bambino può scegliere un oggetto simbolico da una scatola teatrale e costruire attorno ad esso una piccola storia. Da lì nascono scene, mini-dialoghi, riflessioni spontanee. Tutto è pretesto per allenare l'espressività, il linguaggio, la fiducia, la capacità di simbolizzare e di esplorare le proprie paure scolastiche in forma protetta.
Con gli adolescenti, il setting cambia. L'inizio della seduta è spesso verbale, uno scambio informale, mai frontale. Si cerca un punto di aggancio: un fatto accaduto in classe, un voto andato male, una sensazione di blocco. Da lì si parte per passare gradualmente al corpo. Si lavora molto con esercizi teatrali di ruolo: si simula un'interrogazione davanti a un "professore immaginario" e si esplorano i pensieri che bloccano, le reazioni fisiche, i meccanismi automatici di fuga o compiacimento. Oppure si propone un dialogo fra due "parti interne": ad esempio, la voce critica ("non ce la farai mai") e quella più saggia ("hai studiato, fidati di te"). Si usano anche strumenti come il "gioco delle sedie interiori", ispirato al teatro psicologico di Moreno, dove ogni sedia rappresenta una emozione o un punto di vista, e lo studente si sposta da una all'altra per dare voce alle sue ambivalenze. Tutto questo viene accompagnato da esercizi di respirazione consapevole, presenza scenica, articolazione della voce, per rafforzare la padronanza del sé in situazione.
Un altro strumento spesso usato con gli adolescenti è la scrittura drammatica: si chiede loro di immaginare una scena scolastica ricorrente e riscriverla come se fossero registi. Cosa cambierebbero? Chi vorrebbero essere in quella scena? E da lì, si costruisce uno sketch che può essere recitato insieme o semplicemente immaginato ad alta voce.

Dopo il colloquio con i genitori e i primi momenti di conoscenza con lo studente, qualcosa cambia. È come se si aprisse una porta. Non si tratta più soltanto di ascoltare ciò che non funziona, ma di cominciare a costruire. Da qui in avanti, il percorso prende una direzione nuova: educativa, attiva, creativa.
Non si lavora più "sul problema", ma sulla possibilità. L'attenzione si sposta dal sintomo — la fatica, il voto basso, la svogliatezza — al potenziale. Si comincia a esplorare ciò che può nascere, e lo si fa attraverso il linguaggio vivo della scena. È questo il momento in cui lo spazio cambia funzione: da luogo di racconto diventa luogo di azione. E lo studente, gradualmente, passa da oggetto di osservazione a protagonista del proprio cambiamento.
La voce, il corpo, il movimento, l'immaginazione: ogni elemento entra in gioco per trasformare l'esperienza scolastica da passiva a partecipata. Si comincia a sperimentare, a provare, a sbagliare e a rifare. Non per ottenere un voto, ma per scoprire nuove forme di apprendimento e nuove versioni di sé. Ed è proprio in questa fase che la Pedagogia Scenica Integrata dispiega tutto il suo valore: rendere il sapere un'esperienza incarnata, significativa, trasformativa.
Da questo momento in poi, si sale in scena.

Facciamo un esempio. Se uno studente ha difficoltà con la storia, non gli si chiede di studiare la Rivoluzione Francese davanti a un libro. Gli si propone di "diventare" un personaggio dell'epoca, di scrivere una lettera immaginaria a un altro protagonista, di mettere in scena un processo rivoluzionario o un dialogo tra monarchia e popolo. Così la materia prende vita, diventa incarnata, vissuta, memorizzata attraverso emozione, azione, empatia.
Oppure, se la fatica è nella comprensione di un testo letterario, lo si può portare in scena. Si lavora sulla voce, sul ritmo, sull'intenzione. Si chiede allo studente: cosa direbbe questo personaggio oggi? Come si muoverebbe? Come reagirebbe a un tweet o a un'interrogazione scolastica? In questo modo, si sviluppa la capacità interpretativa, si potenzia il pensiero critico, si allena la rielaborazione personale. Tutte competenze trasversali che, poi, fanno la differenza anche nei compiti in classe.
Il coach non si sostituisce all'insegnante, ma affianca il percorso scolastico attraverso un metodo che va alla radice: potenzia l'attenzione, la memoria, l'organizzazione, la gestione dell'ansia. Aiuta lo studente a riconoscere il proprio stile di apprendimento, a sviluppare strategie efficaci, a trasformare l'errore in risorsa scenica. E lo fa mettendo in campo tecniche teatrali, simulazioni, giochi di ruolo, letture interpretate, dialoghi socratici, micro-scritture drammaturgiche, esercizi sul tempo e sullo spazio del pensiero.
In questo quadro, ogni materia può diventare scena. La matematica, ad esempio, può trasformarsi in una sequenza coreografica per esplorare il concetto di simmetria o proporzione. La grammatica diventa dialogo tra parole-personaggi. Le scienze si esplorano costruendo piccole drammaturgie sulla cellula, sul sistema nervoso, sulle leggi della fisica.
Il sapere, dunque, non è trasmesso, ma costruito. E costruito in modo attivo, partecipato, emozionante. Il coach insegna, eccome. Ma insegna come si fa in teatro: partendo dalla relazione, dall'ascolto, dal corpo, dal ritmo. Insegna a stare sulla scena della scuola con più presenza, più fiducia, più autonomia. Anche quando i riflettori sembrano spenti.

L'INGLESE CON LA PSI – UN ESERCIZIO
Numerose ricerche nell'ambito delle scienze cognitive hanno dimostrato che l'apprendimento di vocaboli stranieri risulta significativamente più efficace quando le parole vengono incorporate in una messa in scena e pronunciate ad alta voce per accompagnare un'azione concreta. Tale modalità sfrutta la memoria motoria e la componente multimodale dell'esperienza, creando un ancoraggio più stabile rispetto alla semplice memorizzazione passiva. L'evidenza empirica conferma che l'uso teatrale e performativo del linguaggio potenzia sia il ricordo a lungo termine sia la rapidità di richiamo lessicale.
Ecco un monologo comico che si ispira a un esercizio di "memoria in scena", ma trasformato in un piccolo sketch teatrale dove l'oggetto diventa anche parola immaginata e mimata da tradurre in inglese. L'associazione con l'oggetto pensato e mimato fisserà la parola nella memoria.
MESSA IN SCENA
STUDENTE:
Mini-sequenza teatrale comica – La frittata bruciata
(Lo studente entra in scena, affamato. Si gratta la testa, apre le braccia come a dire "Che faccio?"
Battuta: "Oggi mi preparo una bella frittata… Italian omelette."
Gesto: con le mani mima una padella immaginaria che mostra al pubblico.
Apre due sportelli invisibili.
Battuta: "Apro il frigo… fridge… e prendo le uova… eggs. Una, due, tre… già mi sento un cuoco stellato… star chef!"
Gesto: rompe le uova in una ciotola, fa una smorfia quando cade un guscio.
Battuta: "Ops, il guscio… shell… è caduto dentro! Vabbè, proteine extra."
Solleva la padella immaginaria come fosse un trofeo.
Battuta: "Prendo la padella… pan… e l'olio… oil."
Mima di versare olio abbondante con esagerazione.
Mima di accendere il fornello.
Battuta: "Accendo il fornello… stove… e già mi sento Gordon Ramsay."
Mescola nella padella.
Battuta: "Verso l'uovo… egg… nella padella… pan. Mescolo con la forchetta… fork… anzi no, ho preso il cucchiaio… spoon. Boh, tanto brucerà lo stesso."
Gesto: si dà una botta in fronte, tipo "Che scemo!".
Annusa, tossisce, sgrana gli occhi.
Battuta: "Ahi ahi, odore di bruciato… burning smell! Giro la frittata… italian omelette… ma lei non gira, lei si ribella! È diventata un mattone… brick!"
Gesto: batte il mattone sul tavolo, fingendo che faccia tremare tutto.
Sconsolato riapre il frigo.
Battuta: "Va bene… missione fallita. Apro di nuovo il frigo… fridge… e prendo la mia salvezza: una scatoletta di tonno… a can of tuna."
Mima di aprire la scatoletta con cerimonia, la posa con solennità.
Battuta: "La metto sul tavolo… table… e apparecchio. Ecco il piatto… plate… il cucchiaio… spoon… il coltello…knife… e la forchetta… fork."
Gesto: apparecchia con eleganza come se fosse a un ristorante di lusso.
Si siede e subito si rialza.
Battuta: "Ah, dimenticavo: la bottiglia d'acqua… water bottle… e il bicchiere… glass.
Torna a sedersi.
Ecco qua, una cena da re… a king's dinner … o almeno da sopravvissuto… survivor!"
Gesto: inchino comico al pubblico, la scatoletta in mano come trofeo.
Le pronunce:
fridge – frig
eggs – egs
shell – scell
frying pan – fraiing pen
oil – oil
stove – stov
fork – forc
spoon – spun
burning smell – burning smel
brick – bric
tuna can – ciuna chen
table – teibol
plate – pleit
knife – naif
bottiglia d'acqua - uòter botol
bicchiere – glas
dinner – dinner
king – king
survivor - survaivor
Se sei uno studente che desidera migliorare il proprio metodo di studio, affrontare con più serenità le sfide scolastiche o ritrovare motivazione, oppure un genitore che vuole offrire al proprio figlio un'opportunità di crescita personale e autonomia, ti invito a partecipare a un incontro individuale conoscitivo sulla Pedagogia Scenica Integrata.
Un'occasione per scoprire come questa nuova disciplina può fare la differenza, dentro e fuori la scuola.
Per informazioni:
📧 consigliocoach@gmail.com
📞 327 463 5132